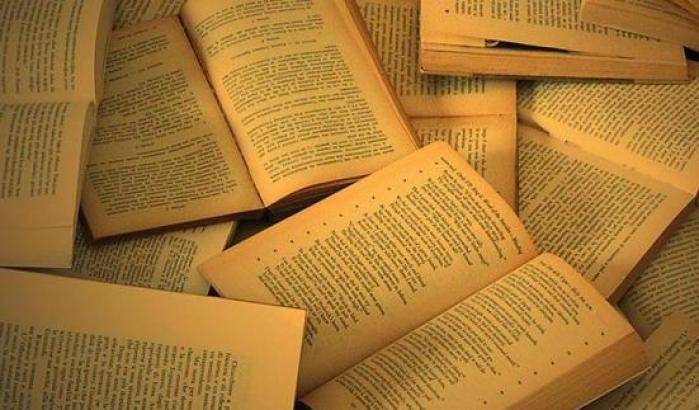Una grande lezione di storia, di cultura, che intreccia passato e presente per dare un orizzonte umano al futuro. La lettura del pezzo di Eran Rolnik su Haaretz è qualcosa che ti prende e coinvolge in tutti e con tutti i sensi. Fin dal titolo: Un olocausto ritenuto incomparabile alle atrocità attuali smette di fungere da monito
Scrive Rolnik: “Alcuni paragoni provocano indignazione già solo per il fatto di essere menzionati. In Israele, spesso basta un vago accenno all’Olocausto per scatenare una reazione che considera tale gesto una violazione morale, non solo un errore intellettuale.
I tentativi di riflettere sul presente israeliano – l’erosione delle norme democratiche, la migrazione delle pratiche coercitive dai territori occupati all’Israele propriamente detto, una cultura politica sempre più autoritaria – attraverso una lente storica più ampia sono spesso accolti con ansia. Il timore non è solo quello di commettere un errore, ma anche di commettere un sacrilegio: che paragonare i processi emergenti di fascistizzazione in Israele al nazismo possa minare la singolarità della catastrofe che ha colpito il popolo ebraico nel secolo scorso.
Il ricordo dell’Olocausto deve fungere da monito, non solo su ciò che è stato fatto agli ebrei, ma anche su ciò che gli esseri umani sono capaci di fare gli uni agli altri.
Tali reazioni, tuttavia, oscurano una distinzione cruciale, che è al centro del pensiero storico: la differenza tra relativizzare il crimine morale e storico senza pari dell’Olocausto – che equivale a negarlo – e universalizzare con cautela i meccanismi umani, politici e psicologici che hanno reso possibile l’Olocausto e che continuano ad esistere nelle società odierne.
Il paragone non pretende identità o simmetria. Non dice: “È la stessa cosa”. Si chiede come avvengono le cose, non quanto diventano estreme. Il suo scopo è identificare i processi politici e sociali prima che raggiungano il punto di non ritorno. In questo senso, il confronto è uno strumento di pensiero storico e di responsabilità morale, non di accusa o di appiattimento delle differenze.
In un’epoca in cui il concetto stesso di verità è sotto attacco, l’universalizzazione è diventata sospetta. Ogni generalizzazione è considerata una negazione dell’unicità dell’Olocausto; ogni tentativo di discernere modelli è respinto come un’analogia eccessiva.
Ma senza universalizzazione non può esserci pensiero morale. Ogni evento rimane chiuso in se stesso, ogni verità si dissolve in una narrazione locale immune alle critiche e ogni trauma si trasforma in un patrimonio identitario che non deve essere toccato.
L’Olocausto mette alla prova la distinzione tra relativizzazione e universalizzazione. La singolarità storica di questa calamità è indiscutibile. Ma se tale singolarità la rimuove da ogni contesto umano, essa perde la sua forza etica e serve solo come scudo contro il confronto con le realtà politiche e psicologiche. Un Olocausto ritenuto incomparabile cessa di funzionare come monito; diventa un monumento sacro e inaccessibile. Smette di porre domande sugli esseri umani e inizia a esigere silenzio.
Hannah Arendt è stata tra le prime a insistere sul pensiero comparativo riguardo al totalitarismo. Ha paragonato il nazismo allo stalinismo non per offuscare l’unicità del genocidio degli ebrei, ma per comprendere le condizioni politiche, istituzionali e psicologiche che lo hanno reso possibile. Ha messo in guardia dal trasformare l’Olocausto in un evento quasi metafisico, extra-storico, al di là del pensiero critico. Per Arendt, il pericolo non risiedeva nel paragone, ma nel separare l’evento dalla storia umana e dalla natura umana.
Le opinioni di Arendt sul sionismo acuirono la tensione tra la natura irripetibile della “soluzione finale” e le lezioni politiche e psicologiche che essa contiene per le generazioni future. Lei sosteneva la creazione di una patria nazionale ebraica come risposta politica alle persecuzioni storiche, ma si opponeva al fondare la legittimità della sovranità ebraica sul trauma.
L’Olocausto è diventato il trauma scelto da Israele, una fonte di coesione ma anche un meccanismo che rafforza l’esenzione morale e diminuisce il senso di colpa e la volontà di riparare.
Uno Stato, sosteneva, non può essere costruito sul ricordo di un’assoluta impotenza senza pagare un pesante prezzo morale. La sovranità organizzata attorno all’Olocausto tende a percepire ogni critica come una minaccia esistenziale e ogni conflitto come una lotta per la sopravvivenza.
Accanto ad Arendt, ma in direzione quasi opposta, si collocava Elie Wiesel, pioniere del dibattito internazionale sull’Olocausto. Egli non agiva in qualità di storico, ma di testimone morale e autorità etica.
Wiesel ha posto l’Olocausto al centro della coscienza globale e lo ha trasformato in un punto di riferimento morale universale. Per un giustificato timore di relativizzazione, tendeva a descrivere la Shoah come un evento che trascende la storia e la comprensione umana, che non può essere paragonato o spiegato completamente. Anche se involontariamente, questa posizione ha contribuito alla mistificazione dell’Olocausto e alla formazione di una norma morale che proibisce il confronto.
La tensione tra Arendt e Wiesel incarna due paradigmi contrastanti della memoria. Uno cerca di comprendere per mettere in guardia, l’altro cerca di santificare per distinguere. Il dibattito israeliano e internazionale sull’Olocausto continua a svolgersi all’interno di questa tensione.
Più di trent’anni fa, lo storico Yehuda Elkana – come Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto – avvertì che la memoria dell’Olocausto poteva passare dalla responsabilità morale a un meccanismo di paralisi politica e morale. Nel suo saggio del marzo 1988 su Haaretz, “In Praise of Forgetting” (Elogio dell’oblio), Elkana non invitava a dimenticare l’Olocausto, ma a smettere di organizzare attorno ad esso l’intera identità morale e politica di Israele.
“L’esistenza stessa della democrazia è in pericolo quando la memoria delle vittime del passato diventa un partecipante attivo nel processo democratico”, ha scritto.
Anche la psicoanalisi insegna che la memoria traumatica – personale o collettiva – quando imposta come principio organizzativo esclusivo non ci aiuta a riconoscere il male come un potenziale umano universale. Al contrario, essa educa le persone a temere il confronto e il pensiero stesso.
L’essenza del tabù odierno può essere sintetizzata in un’osservazione attribuita allo storico dell’arte Fred Licht: “Quando qualcuno inizia a parlare di Hitler e di qualcos’altro, riattacco il telefono”. Per lo studioso dell’Olocausto Yehuda Bauer, questa non era una banalità, ma una posizione storiografica seria nata dalla lotta contro la banalizzazione dell’analogia e l’uso populista dell’Olocausto come scorciatoia morale.
Nel corso del tempo, tuttavia, questa posizione ha subito una trasformazione culturale. Quella che era iniziata come una cautela metodologica si è trasformata in una regola automatica che nega qualsiasi distinzione tra analogia vuota e pensiero comparativo responsabile.
In un’epoca in cui i social media accelerano la disumanizzazione e la politica di massa, e i regimi democratici e quasi democratici perseguitano rifugiati e migranti, la memoria dell’Olocausto non può rimanere un luogo di unicità.
Anche la posizione di Bauer non è rimasta fissa. Nei suoi scritti successivi, ha messo in guardia dai processi di fascistizzazione, erosione democratica e disumanizzazione nella società israeliana, criticando aspramente l’uso politico della memoria dell’Olocausto. Anche coloro che si sono giustamente opposti a confronti semplicistici non hanno mai considerato tale opposizione come un imperativo di silenzio morale.
Il discorso israeliano ha in gran parte interiorizzato il divieto di confronto e, così facendo, continua a neutralizzare l’avvertimento morale e politico insito nella memoria dell’Olocausto. Il passaggio dalla distinzione descrittiva al tabù culturale è ben documentato nel libro di Tom Segev “The Seventh Million”, che ha dimostrato che l’Olocausto non ha sempre occupato un posto centrale nella coscienza israeliana. Il suo ruolo è cambiato in base alle esigenze politiche e nazionali: dal silenzio e dall’imbarazzo nei primi anni dello Stato alla santificazione della Shoah come asse dell’identità.
Se Segev ha tracciato la storia della memoria, il sociologo Moshe Zuckermann ne ha analizzato la struttura psichica e culturale. In “The Holocaust in the Sealed Room” (L’Olocausto nella stanza sigillata), ha mostrato come la memoria non sia dimenticata, ma sigillata, protetta dal contesto, dal confronto e dalla riflessione. Come una stanza sigillata, ha lo scopo di fornire sicurezza, ma impedisce anche la circolazione dell’aria.
Lo psicoanalista americano Vamik Volkan ha introdotto il concetto di “trauma scelto” per descrivere come una collettività adotti un trauma passato come elemento centrale della propria identità. In questo senso, l’Olocausto è diventato il trauma scelto da Israele, una fonte di coesione ma anche un meccanismo che rafforza l’esenzione morale e diminuisce il senso di colpa e la volontà di riparare, bloccando lo sviluppo.
L’uso politico della memoria dell’Olocausto non è stato limitato a un solo schieramento. In un’intervista a Der Spiegel poco dopo la Guerra dei Sei Giorni, il ministro degli Esteri Abba Eban descrisse famigeratamente i confini di Israele precedenti al 1967 come “confini di Auschwitz”. In altre parole, non ha confrontato i risultati, ma ha tradotto un confine politico in una minaccia immediata di annientamento.
Una logica simile opera nell’arena internazionale, in particolare nella designazione da parte delle Nazioni Unite di una Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto. L’Olocausto è riconosciuto come un fallimento morale dell’umanità, ma la sua forza critica universale è ripetutamente neutralizzata dalla diplomazia israeliana. Si può ricordare, provare empatia ed essere inorriditi, ma non si possono paragonare i crimini nazisti contro gli ebrei con qualsiasi altro genocidio. Il tabù del confronto non è infranto, ma regolamentato.
In risposta a questo tabù, negli ultimi decenni è fiorita una tendenza opposta: il confronto tra il nazismo e l’Islam radicale, in particolare le sue correnti antisemite. Si tratta di un confronto storicamente infondato, anche quando una copia di “Mein Kampf” in arabo viene scoperta nella casa di un terrorista o in una scuola nei territori occupati. Il confronto critico dei processi è vietato; il confronto che disumanizza il nemico è permesso. Si scopre che il problema non è il confronto, ma l’identità dell’oggetto e della funzione.
La lotta contro la recrudescenza dell’antisemitismo non può essere condotta separatamente dalla critica dei regimi politici e delle culture che escludono e disumanizzano. L’antisemitismo prospera in contesti in cui le libertà sono limitate, le istituzioni democratiche si indeboliscono e la politica si alimenta della polarizzazione e della ricerca di capri espiatori. Se la memoria dell’Olocausto deve servire come eredità morale, essa impone la resistenza a ogni cultura politica di esclusione, anche in patria.
In un’epoca in cui i social media accelerano la disumanizzazione e la politica di massa, e i regimi democratici e quasi democratici perseguitano rifugiati e migranti, la memoria dell’Olocausto non può rimanere un luogo di unicità. Deve funzionare come un monito contro il collasso dell’umanità che minaccia tutte le persone.
Il potere della testimonianza personale nel plasmare la coscienza dell’Olocausto sta progressivamente diminuendo. Questo capitolo della storia ebraica e umana sarà presto insegnato principalmente attraverso quadri storici, politici, culturali e tecnologici piuttosto che attraverso la memoria vissuta. Questa transizione rende un rigido tabù sul confronto non solo insostenibile, ma controproducente.
La memoria dell’Olocausto non può sopravvivere come luogo di unicità. Se vuole conservare la sua forza etica, deve fungere da monito, non solo su ciò che è stato fatto agli ebrei, ma anche su ciò che gli esseri umani sono capaci di fare gli uni agli altri in determinate condizioni politiche e morali. Un confronto responsabile non è un atto di profanazione, ma una forma di vigilanza.
Una politica della memoria che rifugge da ogni paragone tra Hitler e “qualsiasi altra cosa” non onora i morti né protegge i vivi. Si limita a rafforzare la presa del passato sul presente, restringendo al contempo la responsabilità morale della generazione attuale nei confronti del futuro”, conclude Rolnik.
Quanta verità, quanto coraggio intellettuale in queste riflessioni. Davvero una lezione di cui far tesoro.